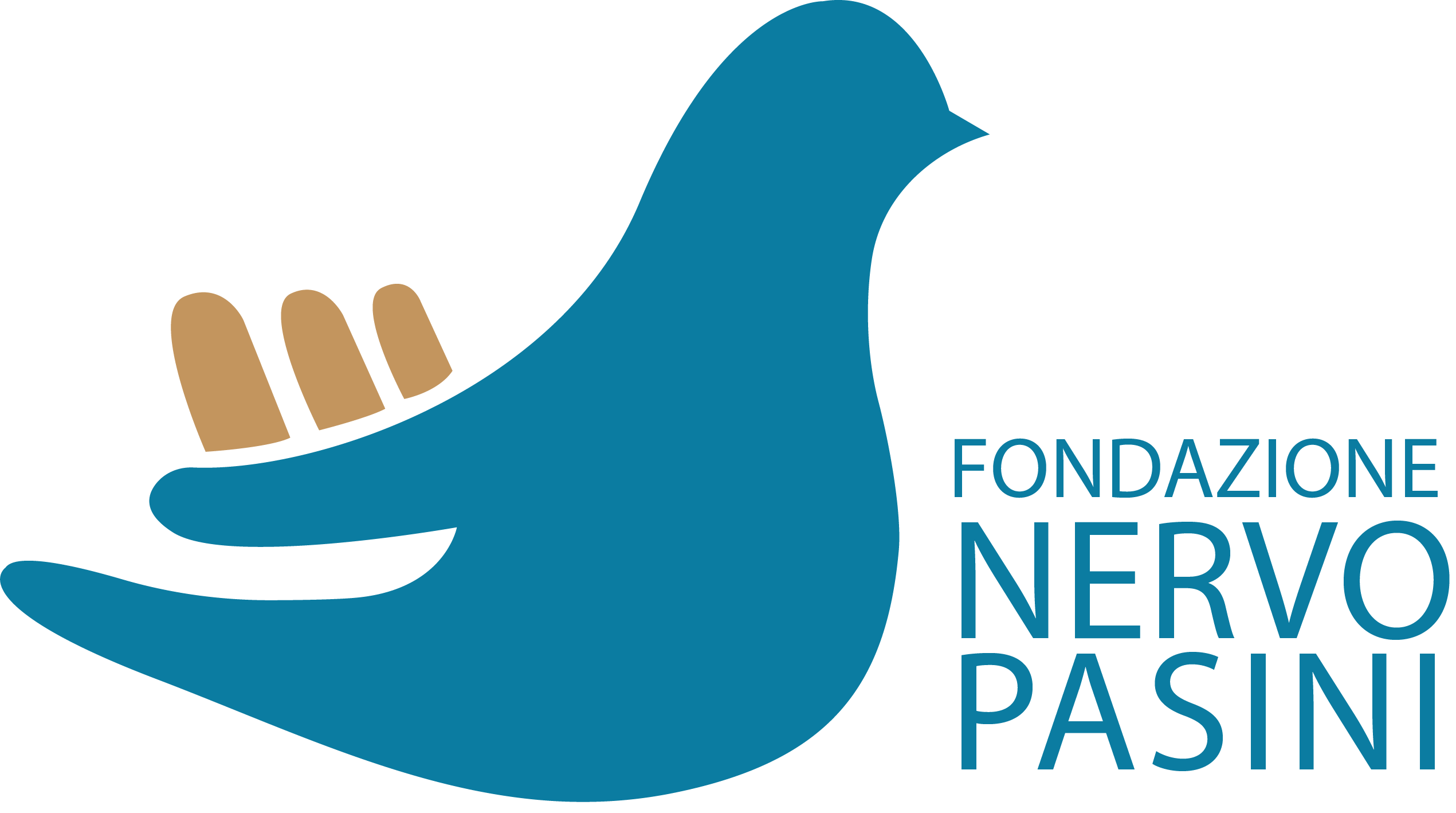Ci sono percorsi accademici che non si limitano a restare dentro le aule universitarie, ma si intrecciano profondamente con la vita reale di una comunità. È il caso di Nina Puglia, studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Innovazione e Servizio Sociale, che ha scelto di dedicare la sua tesi di laurea a un’esperienza concreta di co-progettazione: il caso delle Cucine Economiche Popolari di Padova. Un lavoro che unisce il rigore della ricerca universitaria alla capacità di osservare e interpretare le dinamiche di un contesto vivo, dove servizi, relazioni e innovazione si intrecciano quotidianamente.
Leggi la tesi completa di Nina Puglia
La ricerca: tra teoria e osservazione diretta
Il punto di partenza della tesi di Nina è la co-progettazione, concetto sempre più centrale nelle politiche sociali contemporanee. Nella definizione adottata dal Codice del Terzo Settore, la co-progettazione è il processo attraverso il quale amministrazioni pubbliche ed enti di terzo settore lavorano insieme per individuare, programmare e realizzare interventi sociali, mettendo a disposizione risorse, competenze e responsabilità in maniera condivisa.
Ma la tesi non si limita a collocare il fenomeno in un quadro giuridico. Nina esplora anche la letteratura sull’innovazione sociale, richiamando le teorie che vedono l’innovazione non come un prodotto tecnologico, ma come la capacità di introdurre nuove soluzioni — organizzative, relazionali, metodologiche — che migliorano il benessere delle persone e rafforzano la coesione sociale. Tra i riferimenti, assumono rilievo:
- il concetto di welfare generativo, secondo cui i servizi non solo rispondono ai bisogni, ma attivano risorse e capacità presenti nella comunità;
- i modelli di governance collaborativa, che promuovono processi decisionali inclusivi e distribuiti;
- le pratiche di community building, orientate a rafforzare il tessuto relazionale e il senso di appartenenza.
La cornice teorica è arricchita da un’analisi comparativa di esperienze di co-progettazione in altri contesti italiani, utile per evidenziare similitudini e differenze con il caso padovano. In questo quadro, la ricerca individua fattori chiave come la chiarezza degli obiettivi comuni, la trasparenza nella gestione delle risorse, la capacità di comunicare in modo efficace con tutti gli attori coinvolti e la continuità nel tempo delle collaborazioni.
Sul piano metodologico, Nina ha adottato un approccio qualitativo basato su tre strumenti principali:
- Analisi documentale di convenzioni, progetti e report delle Cep e degli enti partner, per ricostruire la storia e la struttura del processo di co-progettazione.
- Osservazione partecipante nelle attività quotidiane, per cogliere dinamiche informali, linguaggi e modalità operative non sempre evidenti nei documenti.
- Interviste in profondità a figure interne ed esterne (volontari, operatori, rappresentanti di istituzioni e associazioni), per raccogliere percezioni, valutazioni e aspettative.
Questo approccio integrato ha permesso di mettere in relazione le teorie con la realtà concreta, evidenziando punti di forza e aree di possibile sviluppo.
Le peculiarità delle Cep e il loro impatto
L’indagine mette in luce come le Cucine Economiche Popolari siano una realtà con una forte identità, capace di evolvere senza perdere coerenza con i propri valori fondanti. Tra le peculiarità rilevate:
- Radicamento storico e capacità di adattamento: la lunga storia sul territorio non si traduce in rigidità, ma in una solidità che consente di affrontare cambiamenti sociali e nuovi bisogni.
- Servizi come strumenti di inclusione: ogni attività, dal pasto alle iniziative educative, diventa occasione per tessere relazioni, favorire il protagonismo delle persone e stimolare percorsi di autonomia.
- Reti e alleanze costanti: la co-progettazione non è un evento episodico, ma una modalità di lavoro quotidiana, che consente di sviluppare sinergie con realtà diverse e di rafforzare il capitale sociale del territorio.
Sul fronte dell’impatto sociale, la ricerca di Nina sottolinea come le Cep contribuiscano a:
- ridurre l’isolamento e incrementare le relazioni di fiducia;
- facilitare l’accesso a reti di supporto, servizi e opportunità;
- aumentare il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità.
Questi risultati non si esauriscono nei numeri — pure importanti per valutare l’efficacia — ma trovano la loro misura più autentica nelle storie, nei cambiamenti individuali e nei legami che si consolidano nel tempo.
Uno sguardo oltre i risultati
L’analisi di Nina suggerisce che la co-progettazione, per essere realmente efficace, richiede non solo strumenti e procedure, ma soprattutto una cultura condivisa tra tutti i soggetti coinvolti. Significa accettare di mettere in discussione ruoli predefiniti, di aprirsi al confronto e di costruire fiducia reciproca.
In questo senso, il caso delle Cep diventa un laboratorio da cui trarre insegnamenti più ampi: dalla capacità di coniugare servizi e relazioni alla scelta di coinvolgere attivamente chi vive in prima persona i bisogni, fino alla disponibilità a sperimentare e innovare pur mantenendo saldi i valori fondativi.
La tesi lascia in sospeso una domanda che il lettore è invitato a fare propria: quanto siamo disposti, come singoli e come comunità, a condividere responsabilità e decisioni per creare soluzioni realmente condivise? Forse è proprio da qui che può nascere il cambiamento più duraturo.