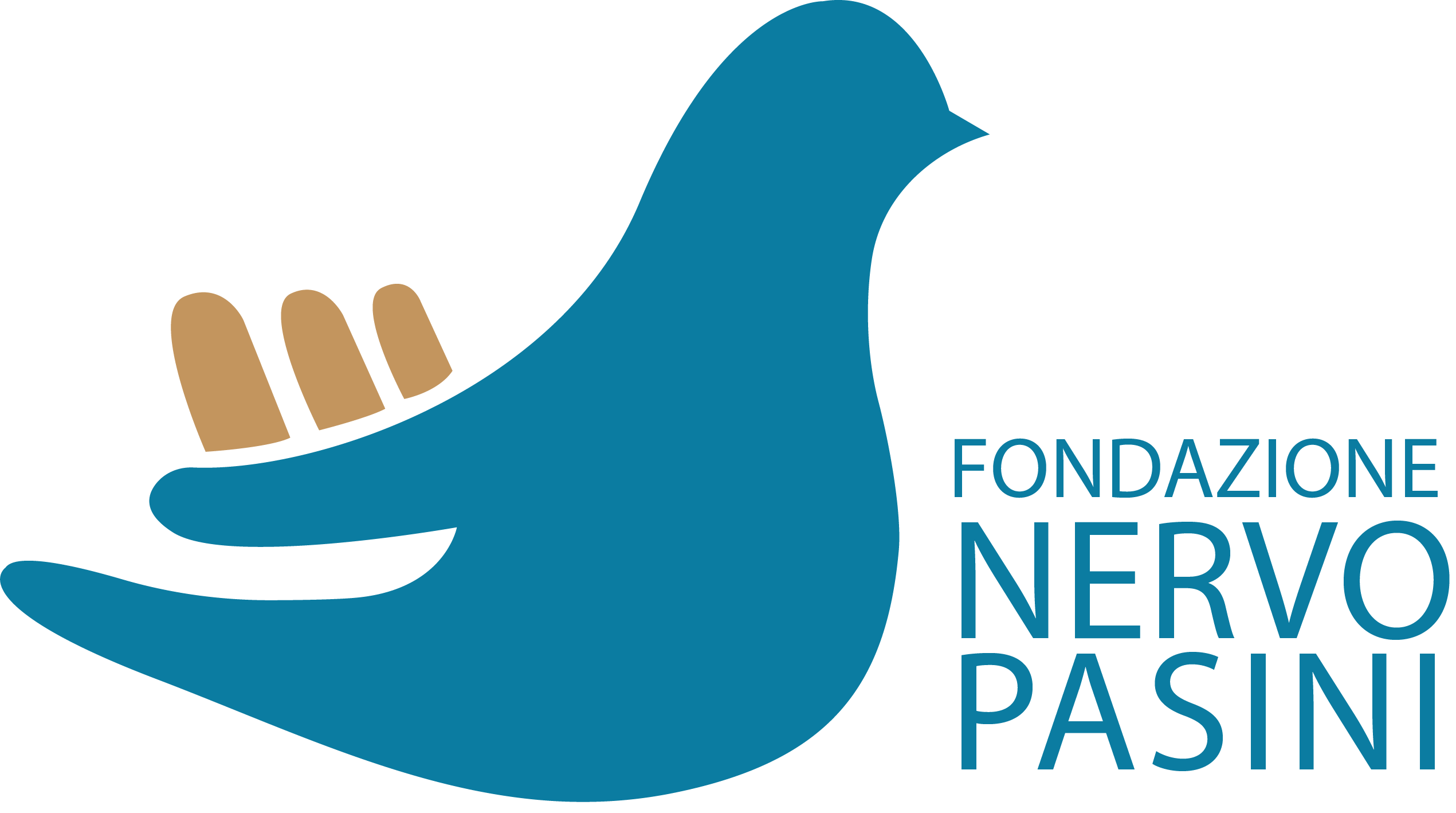Ci sono numeri che orientano il discorso pubblico e luoghi che li rendono visibili. Il Dossier Statistico Immigrazione 2025 (IDOS) descrive un’Italia in cui le migrazioni sono un elemento strutturale: oltre cinque milioni di cittadini stranieri regolarmente presenti, una quota stabile della forza lavoro, fenomeni di mobilità che ridisegnano città e servizi. Dentro questo quadro, il Veneto e Padova mostrano dinamiche composite: economie vivaci, reti sociali diffuse, ma anche frontiere di vulnerabilità che si concentrano nel costo dell’abitare, nella precarietà lavorativa e nell’accesso ai diritti.
Le Cucine Economiche Popolari stanno esattamente su quella soglia in cui i trend statistici diventano volti e gesti quotidiani. Qui passano persone che, per storia e condizioni, rappresentano la parte più esposta dei processi descritti dai report nazionali: working poor, migranti con percorsi irregolari o interrotti, cittadini italiani in povertà urbana, persone senza residenza anagrafica che faticano ad accedere a cure, contributi, graduatorie. La mensa, il servizio sanitario, le docce, il guardaroba sono “luoghi di soglia” dove si osserva come lavoro, casa e salute smettano di essere capitoli separati e tornino a comporre l’unità concreta di una vita.
Italia–Veneto–Padova a confronto… e ciò che vediamo alle Cep
A livello nazionale IDOS conferma alcuni elementi chiave: incidenza stabile della popolazione straniera, forte concentrazione nei servizi alla persona, nella logistica, nell’edilizia e in segmenti dell’agroalimentare; divari di reddito e di tutele che collocano una famiglia straniera su tre in povertà assoluta; fragilità abitative che si esprimono in sovraffollamento, contratti informali, transiti continui tra città e regioni. Il Veneto si colloca nella fascia alta per presenza e partecipazione al lavoro dei cittadini di origine straniera, ma registra disuguaglianze crescenti nelle aree urbane maggiori. Padova, polo di studio e lavoro, attrae e al tempo stesso espone: il mercato dell’affitto è competitivo, gli ingressi nel lavoro spesso collocano le persone nei gradini più bassi delle gerarchie occupazionali, la perdita del posto o la rottura di un contratto fanno scivolare rapidamente in vulnerabilità.
Dentro questo scenario, i dati “di frontiera” osservabili alle Cep aiutano a leggere alcune differenze qualitative. La platea degli ospiti è ampia e composita: 89 nazionalità complessivamente presenti, con una distribuzione che, per i flussi che arrivano alla mensa e ai servizi di prossimità, vede tra le prime Marocco, Nigeria, Italia, Romania e Tunisia. È un profilo coerente con il Nordest, ma con scarti significativi: la quota nigeriana tra chi frequenta i servizi Cep è più alta rispetto alla media cittadina e regionale, segnale di percorsi più esposti a discontinuità abitative e lavorative, e di esiti amministrativi che non sempre approdano a stabilità. Accanto ai cittadini di paesi terzi compaiono inoltre cittadini italiani in povertà urbana strutturale, spesso lavoratori a basso reddito o persone fuoriuscite da reti famigliari fragili: un dato che incrocia i rapporti Caritas sul ritorno di forme di deprivazione “di prossimità”.
La residenza anagrafica è la chiave che apre o chiude le porte dell’inclusione. È la residenza a determinare accesso al medico di base stabile, iscrizione alle graduatorie ERP, contributi comunali, iscrizioni scolastiche, percorsi di presa in carico. Laddove la residenza manca – per perdita dell’alloggio, per mobilità forzata tra province, per situazioni amministrative in sospeso – si forma una zona grigia che IDOS e Caritas descrivono con chiarezza e che alle Cep si incontra tutti i giorni: persone che vivono senza indirizzo e quindi senza diritti effettivi, pur muovendosi e lavorando sul territorio. È qui che la domanda esplicita di un pasto o di una doccia porta con sé domande implicite di cittadinanza: come rientrare nelle regole, come iscriversi ai servizi, come ricostruire un percorso abitativo minimo.
Sul fronte del lavoro, i dati nazionali parlano di un apporto essenziale dei cittadini stranieri e, allo stesso tempo, di una quota non marginale di working poor. La lettura quotidiana delle Cep conferma questo profilo: turni spezzati, contratti a tempo, intermittenza tra settimane di impiego e periodi di vuoto, infortuni o usura fisica che si traducono in tempi di inattività. La richiesta di un pasto, di scarpe da lavoro adeguate, di una ricarica del cellulare per poter rispondere a una chiamata del datore di lavoro, sono indicatori minuti ma precisi di questa economia della precarietà. Il Rapporto Caritas–Migrantes mette in relazione povertà materiale e povertà relazionale/abitativa: la perdita del lavoro o la sua aleatorietà spesso corrisponde alla perdita della casa, e viceversa. In questo incastro, chi perde anche la residenza si ritrova fuori dal perimetro delle tutele.
La salute completa il triangolo. IDOS segnala rinunce alle cure per motivi economici o amministrativi e interruzioni nella continuità assistenziale. Nel microcosmo Cep, il servizio medico-infermieristico intercetta quadri sanitari che altrove scivolerebbero nell’invisibilità: patologie muscolo-scheletriche tipiche dei lavori gravosi, dermatiti professionali, ipertensioni non monitorate, fragilità psichiche non prese in carico. La presa in carico, quando avviene, si regge sull’intreccio tra operatori, personale sanitario volontario, collegamento con i servizi territoriali. Non è solo un accesso a una prestazione clinica; è una riattivazione di canali (documenti, iscrizioni, appuntamenti) che riportano la persona dentro un perimetro di diritto.
Sul versante abitativo – il punto più critico nei report e nelle vite che bussano alla mensa – la fotografia che emerge è coerente con le analisi europee (FEANTSA, Housing Europe): sovraffollamento, canoni non sostenibili per redditi bassi, segmenti di mercato informale, carenza di soluzioni “ponte” tra strada e casa. Padova e il Veneto hanno reti importanti (parrocchie, ETS, progetti di housing sociale), ma le Cep incontrano ogni giorno persone in transito, appena espulse dall’alloggio, o stabilmente senza tetto. In questi casi la priorità concreta si chiama riparo: docce, abiti puliti, un pasto, informazioni chiare sui passaggi possibili. È spesso il primo gradino per riaprire una trattativa con la città: cercare un contratto regolare, rientrare in liste di attesa, riattivare la residenza, riprendere una terapia.
Le Cep come “osservatorio di soglia”: ciò che i numeri dicono quando diventano vita
Osservare da vicino la fila all’ingresso, i turni delle docce, le richieste di orientamento significa vedere come i grandi fenomeni sociali si depositano nella quotidianità. Non serve amplificare: basta registrare, con rigore, che chi arriva alla soglia Cep spesso incarna la punta estrema delle tendenze nazionali. È la parte del fenomeno in cui le curve statistiche “sfondano” nelle vite.
Due elementi, più di altri, aiutano a leggere in profondità questo punto di confine. Il primo è la residenza anagrafica, vera infrastruttura dei diritti: quando manca, tutto il resto diventa più difficile. Lo confermano i report, lo dimostrano le pratiche quotidiane: senza residenza non si stabilizza il medico di base, si fatica a entrare nelle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica, ci si perde tra uffici, modulistica, tempi. Ogni volta che alle Cep si accompagna una persona a recuperare un’iscrizione anagrafica o un cambio di residenza, si compie un atto di cittadinanza che vale quanto un pasto o una visita medica. Il secondo è la continuità: orari chiari, procedure semplici, operatori riconoscibili. In un mondo frammentato, la continuità dei servizi di prossimità ricostruisce fiducia e riapre canali spenti. È lì che i dati trovano carne e voce: nella riconoscibilità delle persone e nella costanza delle risposte.
In questo senso, le Cep non sono solo un “servizio” ma una lente empirica sul presente. Mettono in fila ciò che i report indicano: l’abitare come frontiera decisiva, il lavoro come variabile instabile, la salute come diritto che dipende da carte e indirizzi, le reti come antidoto alla caduta. Che cosa aggiunge l’osservazione locale alla conoscenza nazionale? La specificità dei profili (ad esempio la maggiore presenza nigeriana tra gli utenti di prossimità), la geografia dei bisogni (la densità dell’area stazione come punto di intersezione di mobilità, povertà, servizi), la natura delle domande (che oltre al cibo chiedono orientamento, documenti, accesso). E soprattutto una lezione semplice: ogni diritto, per diventare reale, ha bisogno di un indirizzo e di una relazione.
Fonti essenziali
IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2025.
Caritas–Migrantes, Rapporto Immigrazione 2025.
ISTAT, Condizioni di vita e povertà 2024–2025.
FEANTSA / Housing Europe, Homelessness & Housing Exclusion Reports 2025.
Osservatorio interno delle Cucine Economiche Popolari (dati aggregati su utenza e accessi ai servizi).