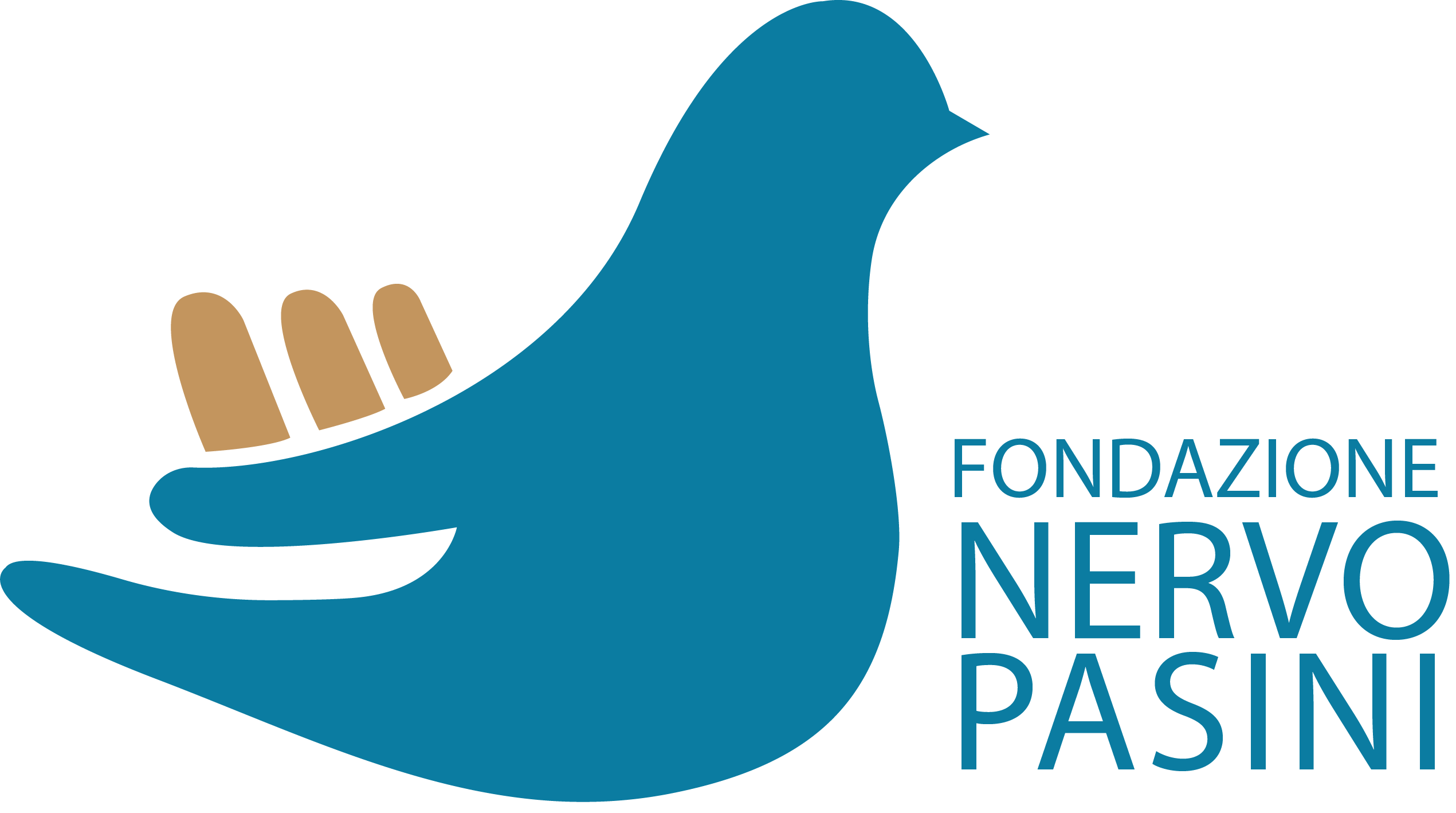Le persone senza dimora non vanno in vacanza, e le Cucine Economiche Popolari nemmeno. Durante l’estate la fragilità aumenta, sia dal punto di vista igienico-sanitario che sociale, proprio quando alcuni servizi sono meno accessibili. I volontari delle Cucine, invece, vogliono esserci, perché considerano la continuità stessa una forma di cura, che richiede comunque attenzione e risorse. Tutto questo è consentito anche da una forte collaborazione con la Diocesi, che sostiene le Cep in modo continuativo, oltre che dalla grande disponibilità dei volontari. Lorenzo Lando, per esempio, era in vacanza, ma è tornato apposta per il suo turno di servizio, per poi ripartire.
«Ho cominciato 14 anni fa per due motivi – ricorda – perché me ne aveva parlato un’amica volontaria e per i racconti di mia madre, che in tempo di guerra lavorava vicino alla Chiesa della Pace. Qui intorno c’erano solo industrie e le mense aziendali non esistevano. Gli operai venivano alle Cucine a scaldarsi un pentolino di minestra o a prendere una pagnotta. In casa se ne parlava. Anche per questo sono venuto qui: per mettermi al servizio degli altri».
Lorenzo, di Villatora, lavorava in un’industria calzaturiera. Come volontario fa un po’ di tutto: a volte sta allo sportello, a volte in sala, o serve il pane e l’acqua a tavola.
«Questa esperienza mi ha fatto cambiare il modo di pensare. Sono stato educato ad essere attento a chi è nel bisogno, e l’ho sperimentato anche in parrocchia. Ma da quando sono qui, ho dovuto… diciamo “correggere il tiro”. Qui ti confronti, conosci le storie, e ti accorgi che le persone non sono come le immaginavi. Molte volte sono storie di abbandono, di dolore, a volte vere e proprie tragedie, ma sono storie di persone che vogliono ritornare nella società. E allora devi metterti in discussione. Io almeno faccio così, ma ognuno fa il proprio percorso. Servire il cibo o pulire i tavoli non sono solo gesti meccanici. È qualcosa di più. Quando torno da qui, vado a casa contento. Non perché salvo il mondo. Io non lo salvo il mondo. Nessuno di noi lo salva. Però ho dato un sorriso, una pacca sulle spalle, un ciao, che nessuno dà per strada, o anche un: “Come stai?”».
Eppure, non sono sempre rose e fiori.
«Sono stato anche ripreso da suor Albina, perché sono istintivo. C’è chi alza la voce per una piccola cosa. Mi è successo di perdere la pazienza. E probabilmente mi succederà ancora, però col tempo sono migliorato (ride, ndr). Adesso so che le persone che vivono per strada d’inverno soffrono il freddo, d’estate il caldo, dormono male. Non possono non essere arrabbiate. La vita stessa li ha portati a un’esistenza che non è quella che vorrebbero, e non sono sempre dell’umore giusto. Dobbiamo, e lo dico soprattutto per me stesso, essere più comprensivi. Ed è ciò che sto cercando di fare».
Anche la scelta di Elena Zuin, 23 anni e volontaria da un anno e mezzo, è stata influenzata dalla madre, che aveva fatto la volontaria ai tempi di suor Lia.
«Quando ha deciso di riprendere, l’ho accompagnata. Il mio desiderio di dedicare qualcosa di me agli altri, stando a contatto con le persone, è in linea col mio progetto di vita, come la scelta di studiare Diritti Umani».
Agli studenti di Diritti Umani, l’Università di Padova offre la possibilità di svolgere attività di volontariato, che viene riconosciuta come parte del percorso formativo.
«Non è obbligatorio – spiega Elena – ma io ho voluto farlo, in una realtà che mi interessava. Faccio servizio la sera, durante l’ora di apertura della mensa. Arrivano una media di 130 persone per chiederti un pasto. Io sto allo sportello e assemblo i vassoi. Questo richiede un po’ di spirito di iniziativa e di adattamento. Un aiuto importante viene dalla solidarietà tra volontari. Ci si scambiano consigli, si condividono le fatiche. A volte hai una sensazione di impotenza, ma confrontarmi con chi fa servizio da anni e continua a impegnarsi mi spinge a fare altrettanto».
Alle Cucine ci sono persone che vengono da 89 paesi diversi. Viene da chiedersi: come si fa a comunicare? A spiegare loro il menù?
«Ci si viene incontro. La solidarietà esiste anche tra gli ospiti. Uno si offre di tradurre, un altro di mediare. C’è chi si spazientisce per l’attesa e chi lo lascia passare o gli spiega che deve essere paziente. Comprendi che la gentilezza e l’empatia non sono innate, ma vanno allenate e hanno sempre un effetto a catena che lascia il segno. Se guardo alla realtà delle Cucine, a cui mi ero approcciata con l’idea del fare, vedo quello che ho ricevuto».
Un esempio?
«Ho imparato ad essere una presenza disponibile, ma non invadente. A volte le persone ti raccontano la storia della loro vita, i loro sogni. Ma non sempre chi ha una brutta giornata apprezza che qualcuno voglia tirargli su il morale. L’altro deve sapere che io ci sono, ma rispetto i suoi ritmi, senza forzare le cose. Questo trascende tutte le differenze culturali. In fondo, le Cucine sono uno dei pochi posti dove una persona senza dimora si sente al sicuro. Dire che sia un ambiente caotico è un pregiudizio. Anzi – precisa Elena – caotico lo è, ma non in senso negativo. Ci sono delle regole dette (ad esempio non introdurre alcolici), ma anche regole non dette, che garantiscono la convivenza, a cui tutti sembrano aderire».
Giancarlo Boaretto e la moglie Donatella frequentano le Cep come volontari da quando sono andati in pensione: lui come tecnico all’Istituto Zooprofilattico, lei come impiegata in un’associazione di categoria.
«Sapevamo che inizialmente sarebbe stato un po’ difficile, ma anche che ci avrebbe fatto bene. È un’esperienza interessante, perché imparando a conoscere gli ospiti ci si rende conto che ognuno ha una propria dignità e deve essere rispettato per quello che è. È positivo anche per i nostri tre figli e per i due nipotini. Spesso se ne parla, e loro ti ascoltano con interesse e curiosità. A volte fanno delle domande».
Anziché andare in vacanza, Donatella e Giancarlo sono stati quindici giorni a conoscere i progetti della Chiesa di Padova in Kenya, al St. Martin CSA (Catholic Social Apostolate), organizzazione religiosa che opera nella zona rurale di Nyahururu.
«È un sogno che avevamo da vent’anni, perché avevamo avuto modo di conoscere molto bene don Gabriele Pipinato, che ha avviato la missione. Da quell’esperienza mi sono portato qui molte domande, ma come occidentale e come europeo, fatico a darmi delle risposte. Anche lì c’è tanta povertà, ma una povertà diversa da quella che si vede alle Cucine. Eppure qualcosa in comune c’è: sia in Africa che qui, le persone continuano ad avere dei sogni, a difendere la loro dignità e a credere nella possibilità di un riscatto».
Madina Fabretto