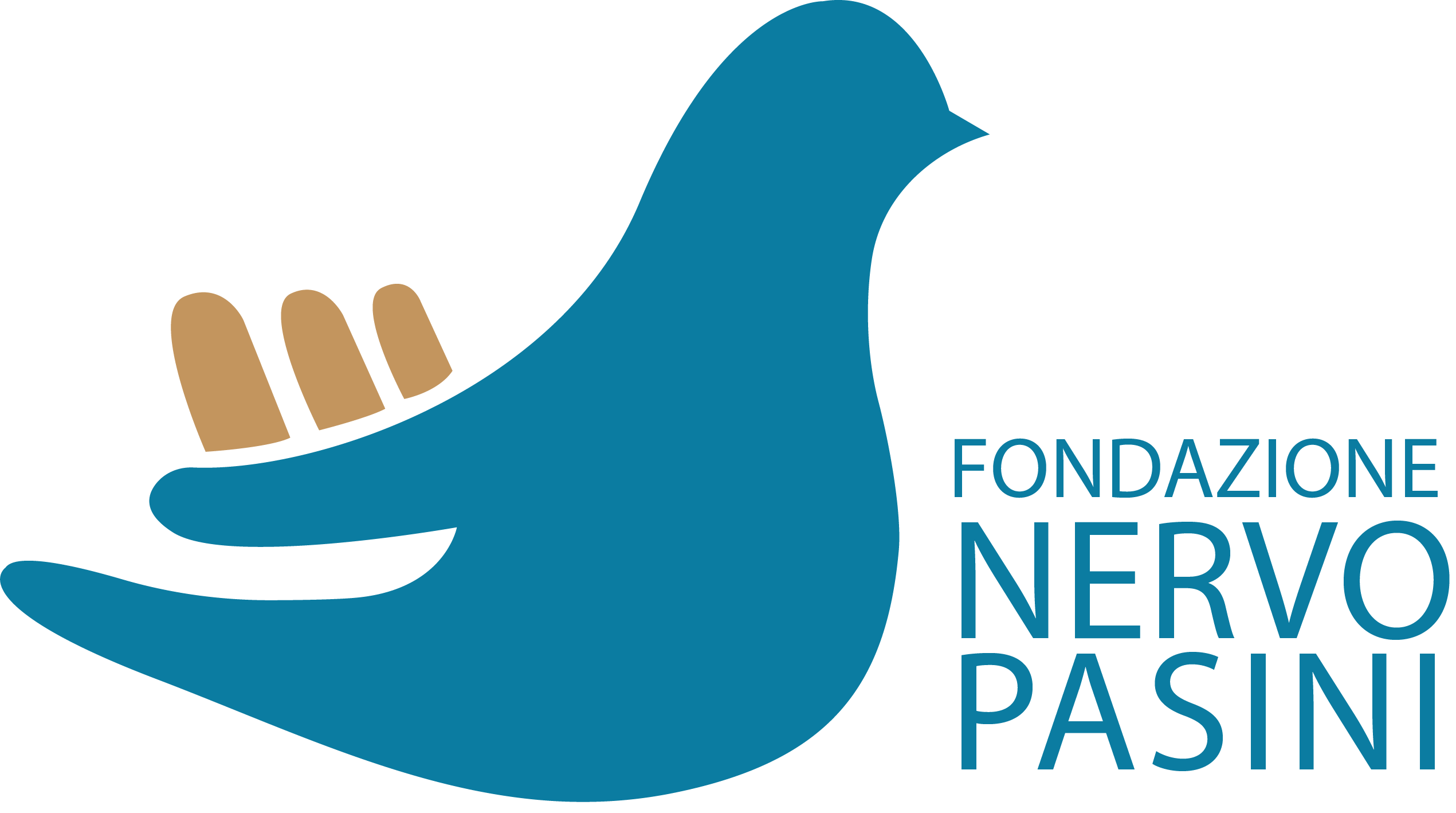Il gradiente sociale della salute: radici e nuove evidenze
Le disuguaglianze di salute sono il risultato di processi storici, economici e politici che incidono profondamente sulla vita delle persone. A ricordarcelo è stata la Commission on Social Determinants of Health dell’OMS (2008), che con il rapporto Closing the gap in a generation ha dimostrato come la salute segua un preciso gradiente sociale: chi parte da condizioni di svantaggio accumula sistematicamente peggiori esiti di salute lungo l’intero arco di vita.
Questo gradiente è osservabile anche in Italia. Lo studio pubblicato da The Lancet Public Health nell’aprile 2025 (State of health and inequalities among Italian regions) evidenzia che, nonostante un incremento medio dell’aspettativa di vita negli ultimi decenni, le disuguaglianze territoriali e sociali si sono consolidate. Le regioni settentrionali mostrano indicatori più favorevoli – maggiore speranza di vita e salute aggiustata, minori tassi di mortalità prematura – mentre il Sud e le Isole registrano livelli peggiori, aggravati dalla carenza di servizi territoriali, dall’invecchiamento e da condizioni socioeconomiche più fragili.
Questi squilibri riflettono l’impatto di determinanti strutturali come il livello di istruzione, il reddito e l’accesso ai servizi. Non è un caso che il position paper di Giuseppe Costa (Salute disuguale e sanità disuguale) insista sul fatto che le disuguaglianze di salute rappresentano la “causa delle cause”: ciò che spiega non solo perché ci si ammala e si muore prima, ma anche perché gli stili di vita e i comportamenti a rischio si distribuiscono in maniera differente tra i gruppi sociali.
In questo quadro, anche la frammentazione del sistema informativo nazionale contribuisce a rendere opaca la lettura del fenomeno. Un editoriale su The Lancet Regional Health (gennaio 2025) ha parlato di “sistema informativo sanitario rotto”: la mancanza di un’infrastruttura unitaria e interoperabile, accentuata dalla crescente autonomia regionale, ostacola la programmazione nazionale e impedisce di leggere con chiarezza le disuguaglianze.
Invisibilità e marginalizzazione: chi resta fuori dal sistema
Se le statistiche mostrano il gradiente sociale, il lavoro sul campo rivela un volto ancora più duro: quello degli “invisibili”. Migranti irregolari, senza dimora, minori non accompagnati, braccianti che vivono nei ghetti rurali, famiglie che abitano in palazzi occupati o insediamenti informali. Tutti accomunati dal rischio di essere esclusi dai diritti sanitari a causa di barriere amministrative e sociali.
Durante la pandemia, la mancanza di residenza o di una tessera sanitaria si è trasformata in un ostacolo insormontabile: senza credenziali digitali, centinaia di migliaia di persone non potevano prenotare tamponi o vaccini. In Italia si stima che gli “invisibili” siano circa 800.000, con almeno 50.000 solo nel Lazio.
Il racconto di operatori come Salvatore Geraci (Caritas Roma) ha evidenziato come il problema non sia solo quello di superare il margine con interventi straordinari, ma di spostare il margine, includendo stabilmente queste persone nel funzionamento ordinario del sistema sanitario. L’invisibilità, infatti, non è solo clinica ma anche amministrativa: il bisogno di cura viene riconosciuto, ma la persona che lo esprime rimane esclusa dal circuito istituzionale.
Questo quadro richiama l’urgenza di leggere la salute dentro le dinamiche di marginalizzazione. Le traiettorie di vita degli esclusi non dipendono da scelte individuali, ma dall’intreccio di fattori economici, abitativi, occupazionali e relazionali che condizionano l’accesso alle opportunità di benessere. Ecco perché ridurre le disuguaglianze significa intervenire su politiche abitative, su misure di contrasto alla povertà, su servizi sociali capaci di supportare le persone nelle fasi critiche della vita.
La sanità pubblica di prossimità come risposta
La prospettiva più promettente è quella della Sanità Pubblica di Prossimità (SPP), elaborata a partire dalle esperienze sul campo e da riflessioni teoriche recenti. Questo modello propone di integrare tre azioni fondamentali:
- outreach: andare verso le persone nei quartieri, nelle periferie e negli insediamenti informali, superando la logica della sola presa in carico in ospedale o in ambulatorio;
- mediazione di sistema: ripensare i servizi in chiave più accessibile, semplificando procedure, riducendo barriere linguistiche e burocratiche, rafforzando il ruolo dei mediatori culturali;
- empowerment comunitario: sostenere le reti sociali e il protagonismo delle comunità, affinché non siano solo beneficiarie ma parte attiva dei processi di salute.
Questo approccio si colloca dentro una più ampia visione di salute globale, che invita a leggere i fenomeni sanitari come esiti di relazioni complesse tra ambiente, economia, società e politiche pubbliche. La salute non è mai solo individuale, ma dipende dai legami che connettono le persone tra loro e con il contesto naturale e sociale.
Contrastare le disuguaglianze di salute in Italia significa allora ricostruire un patto di cittadinanza sanitaria, in cui il diritto alla cura sia garantito realmente a tutti, con più risorse destinate a chi parte da condizioni di maggiore svantaggio. Significa anche rafforzare la dimensione territoriale del sistema sanitario nazionale, oggi minacciata da carenze di personale, da processi di privatizzazione e da rischi di frammentazione legati all’autonomia differenziata.
La sfida è trasformare le pratiche sperimentali in normalità: far sì che ciò che oggi viene fatto come progetto speciale – un ambulatorio di strada, un poliambulatorio a bassa soglia, un intervento mirato di prossimità – diventi parte integrante del sistema. Solo così sarà possibile ridurre davvero il gradiente sociale di salute e costruire una sanità più equa e inclusiva.
Fonti principali:
- Commission on Social Determinants of Health, OMS (2008), Closing the gap in a generation
- State of health and inequalities among Italian regions (The Lancet Public Health, 2025)
- The Italian health data system is broken (The Lancet Regional Health, 2025)
- S. Geraci, Spostare il margine per una sanità più equa e più inclusiva
- G. Baglio, E. Eugeni, S. Geraci, Salute globale e prossimità
- G. Costa, Salute disuguale e sanità disuguale
- A. Rinaldi, M. Marceca, I determinanti sociali della salute